[Roma 2012] A Walk in the Park, la recensione
Il primo film dell'ambiziosa sezione CinemaXXI racconta la vita disperata di Brian Fass, ossessionato da una madre troppo protettiva da cui non è mai riuscita pienamente a emanciparsi...
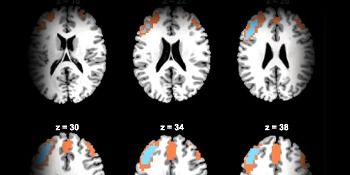
La vita di un direttore della fotografia di horror piuttosto dozzinali viene narrata con stile documentaristico-psichedelico dal cantore della No Wave newyorchese Amos Poe, autore importante del cinema americano indy degli '80.
Si respira un'aria da racconto morboso di ricca famiglia yankee malata alla Andrew Jarecki (Una storia americana, Love & Secrets) in questo fin troppo autoindulgente A Walk in the Park (sezione CinemaXXI), confessione in camera con faccia oscurata di Brian Fass, appassionato di cinema e poi professionista della settima arte nel reparto fotografico con una vita alle spalle ricca di traumi e psicofarmaci. Tutto nasce da un rapporto malsano con una madre fin troppo attaccata al figlio. Per troppo amore lei, sposata a un ricco avvocato dal quale poi divorzierà, renderà Brian insicuro e incapace di affrontare il mondo che lo circonda. Strutturato in capitoli il film di Poe affronta tutti i disastrosi effetti del rapporto tra Fass madre e Fass figlio e Brian, spiace dirlo, in più di un'occasione suscita ironia piuttosto che compassione. C'è anche molto meno coraggio di quanto si vorrebbe far credere. Perché, ad esempio, la vita sessuale del protagonista viene affrontata in tre minuti scarsi? In fondo si tratta di una storia di crisi familiare trita e ritrita con il fratello scavezzacollo (amante della marijuana) e il padre che scappa con un'altra donna.Grazie a un fin troppo caleidoscopico montaggio digitale (le pericolose potenzialità di Final Cut Pro), Poe divide lo schermo, inserisce “godardianamente” parole-citazioni da Jean-Jacques Rousseau, Nabokov, Poe (lo scrittore), Carroll e associa la storia di Brian a Psyco e Il corridoio della paura attraverso inserimenti letterali nella sua opera di questi due capolavori della malattia mentale. Che dire? Il soggetto meritava tutta questa enfasi? A nostro parere no. E poi il documentario di Poe è troppo lungo. Poteva durare tranquillamente 20 minuti piuttosto che 96'.
Una lunga, e inutile, parentesi sull'amore tra Brian e Central Park (ecco il perché del titolo) non fa altro che peggiorare la situazione e far affondare l'operazione nella più fiacca autoindulgenza tipica di un certo approccio indy al cinema. E alla vita.