Alien: Covenant, la recensione
Pieno di alieni che rimangono un po' in secondo piano, Alien: Covenant svela l'idea di Ridley Scott per il nuovo franchise ma soffre di manie di grandezza

Il paradosso è che Covenant, come molti dei suoi predecessori, continua a rispettare in pieno la struttura originale: la lenta carneficina, la scansione dei vari momenti, la passione per il meccanismo di fuga e nascondimento dello xenomorfo fino alla grande sfida finale con gli esseri umani che è solo apparentemente impari. Insomma quel meccanismo per il quale crediamo di assistere alla storia di alcune persone braccate da una creatura letale, mentre invece ci accorgiamo lentamente di assistere alla suddetta creatura a contatto con quello che ormai evidentemente è il proprio nemico naturale: la donna, il corpo fragile per eccellenza ma anche quello dotato della determinazione maggiore. È questa caccia come sempre la componente migliore di un franchise ancora capace di partorire alcune delle migliori scene di azione e suspense in circolazione, momenti capaci di unire il respiro di ampi scenari all'uso di dettagli che imprimono un grande ritmo (una scivolata su una macchia di sangue, uno strumento che rimane incastrato, un piede che blocca una porta).
Su questo impianto immortale Alien: Covenant poi incastra anche l’altra trama, quella che già in Prometheus coinvolgeva gli Ingegneri e l’androide David di Micheal Fassbender, a tutti gli effetti la vera spina dorsale del progetto. È qui però che inevitabilmente finiscono marginalizzati gli alieni xenomorfi, moltiplicati in numero come in Aliens ma decisamente ridotti in importanza, peso e terrore. È la vera differenza tra i molti film di Alien non realizzati da Ridley Scott e questi nuovi: gli alieni del titolo non sono unicamente la specie sanguinaria che massacra e uccide esseri umani ma comprendono anche gli Ingegneri, che invece gli esseri umani li hanno creati.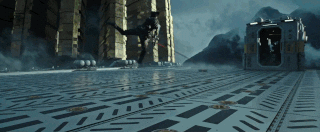
Nonostante tutti i tentativi quindi sembra ancora che Alien dia il suo meglio quando entrano in ballo le creature di Giger (e paradossalmente quando si tratta delle creature originali, non le diverse variazioni), quando cioè riesce a essere un fantastico survival horror, un B movie col budget di un blockbuster. Dall'altra parte quando invece si occupa di temi e idee più elevate, quando ambisce a ragionare su creatori e creati, sfiora di nuovo il ridicolo involontario di Prometheus. Ridley Scott conferma infatti una sorta di imbarazzo nel trattare i suoi personaggi come persone (o androidi) complessi, dotati di dubbi, aspirazioni e contraddizioni a fronte di un'abilità esaltante nel farli muovere, correre e scappare. Quando si comporta da film sofisticato insomma Alien: Covenant sembra un elefante in una cristalleria; quando invece decide di sporcarsi le mani con un po’ di materia rozza (per fortuna la maggior parte del tempo), riesce a mostrare qualcosa di intimo e pericoloso, di suggestivo e calamitante.
Dalla cima dell’astronave in decollo fino alle rituali “nascite aliene” (stavolta ce ne sono un paio in contemporanea da antologia del cinema di tensione) e poi ancora nei classici corridoi metallici, Scott continua a unire come nessun altro la tenacia femminile alla tensione dell’azione, divertendosi non poco nell'immaginare gli esseri umani che impazziscono di fronte all’essere ridotti a prede.E se il design, la tavolozza dei colori usati e gli ambienti sono presi a piene mani da Prometheus, come giusto e prevedibile, è la colonna sonora questa volta a distinguersi per un sound anni ‘50/’60 rivisto e modernizzato che sembrerebbe gridare e sperare, come lo spettatore, di appartenere ad un grande B movie dall’inizio alla fine.
Nota: l'articolo è stato modificato in data 8/5/2017