The Social Network, 10 anni fa David Fincher andava "il più vicino possibile ad un film di John Hughes"
Rivedendo completamente la mitologia del college, The Social Network raccontava prima il suo tempo e il nuovo mondo competitivo e solo poi Facebook

Qualsiasi grande film dice molte più cose di quelle contenute nella sua trama. The Social Network è un film gigantesco, uno dei più importanti del decennio. Di certo uno dei più sorprendenti, la tempesta perfetta: l’unione impossibile del miglior copione scritto dal miglior sceneggiatore americano in attività con uno dei registi più raffinati e ossessionati dal comparto visivo in circolazione nel suo periodo creativamente migliore, coronata da un cast di attori che sarebbero diventati star, volti sconosciuti o quasi la cui mitologia veniva fondata in quel momento con quei personaggi.
La trama racconta l’origine controversa e battagliera di una delle piattaforme tecnologiche determinanti del nostro tempo, ma molte delle cose che il film dice riguardano in realtà il mutamento generazionale americano, la pressione sui 19enni, l’aspirazione gigante che serpeggia nei college e la feroce lotta di classe nella Ivy League. Solo dopo arriva la solitudine dell’uomo che ha fondato le tecnologie sociali. E dopo ancora la storia della nascita di Facebook.
LEGGI: The Social Network, la lettera aperta di Aaron Sorkin sulla libertà di parola rivolta a Facebook
LEGGI: David Fincher su Mank e lo stato di salute del cinema: “Ormai ci sono solo due generi di film, spandex estivo e sofferenza invernale”
LEGGI: Mank: online le prime recensioni dell’atteso nuovo film di David Fincher
Nessuno aveva mai trattato così seriamente la programmazione e l’informatica. In The Social Network il codice è come un libro, come un brano musicale, una scultura o film, è una creazione originale preziosissima, un affare serissimo, possibilmente milionario e di certo individuale, personale. È il protagonista. Sembrano pazzi i gemelli Winklevoss ad affidarsi a qualcun altro per crescere la propria creatura e sembra davvero avere ragione Zuckerberg quando dice: “Non c’è nemmeno una linea del codice di Facebook che sia copiata”. Fino a quel film il mondo dell’informatica che era tra di noi, era nella società e nelle vite di tutti, veniva trattato come una roba da hippie o da freak, che viveva di regole sue e in cui non entravano i più comuni sentimenti.
Di film sulla novità del momento ce n’erano stati e non solo erano brutti (e va bene) ma erano diversi perché parlavano di noi (il pubblico) pretendevano di raccontare l’effetto di Facebook su di noi, come sempre il cinema racconta la tecnologia: mostrando le sue conseguenze sull’utente. The Social Network raccontava invece il mondo in cui era nata e, trattandola come un contenuto creativo inestimabile, raccontava senza far sconti come si formi l’eccellenza oggi e a che prezzo.

Tutto nella storia della produzione di The Social Network è andato in quella direzione, a partire dal casting, trasformandolo in una specie di film di John Hughes amaro, scritto come un legal thriller. Aaron Sorkin infatti è pur sempre l’uomo che è emerso scrivendo Codice d’onore e che ora ha trovato un grande successo in Il processo ai Chicago 7, è un maestro del cinema di tribunale, e The Social Network è quello, nonostante la maschera. È una serie di deposizioni, di domande difficili e risposte ancor più dure, in cui qualcuno deve spiegare cosa accadde e raccontare come si sentisse (tantissime le domande in quella direzione) davanti ai diretti interessati, guardando negli occhi i rivali. Solo che poi possiamo vedere quello che viene rievocato dalle testimonianze, tutti i punti di vista diversi.
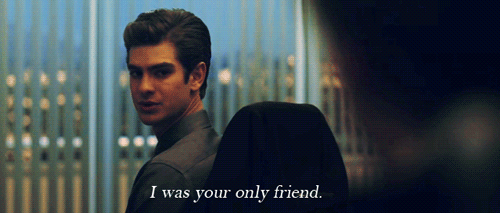
Questo rarissimo caso di film instant, pieno di riferimenti al proprio tempo che racconta una storia accaduta da pochissimo, che tuttavia riesce a diventare un classico senza tempo (e ora dopo 10 anni possiamo dirlo come un’affermazione e non come una previsione), è tutto centrato su un cast di quasi esordienti.
Con l’eccezione di Andrew Garfield, che non era ancora esploso ma era già stato in Parnassus di Terry Gilliam, e di Justin Timberlake, il resto del cast fu scelto tra attori sconosciuti, di fatto facendo esplodere un’intera generazione.

Armie Hammer, Jesse Eisenberg, Rooney Mara, Max Minghella e anche in ruoli piccolissimi Dakota Johnson e Caleb Landry Jones (che avrebbe dovuto aspettare 7 anni, cioè la parte in Get Out, per esplodere). Questo accade quando Fincher può scegliere liberamente il cast e assegnare ruoli alle facce giuste e gli attori migliori. Un esempio: Garfield era in lizza per interpretare Zuckerberg (come anche Shia Labeouf e Michael Cera), ma Fincher dai provini di un personaggio algido aveva comunque capito subito che la qualità migliore di questo d’attore è un’incredibile calore, una grande umanità e una fragilità uniche, tutte doti inutili per il personaggio protagonista, ma perfette per Eduardo Saverin.

Su questo impianto Fincher mette la sua magia, cioè quel mestiere che aveva già affinato in decenni di videoclip. C’è il suo mondo di tenebre, cioè i toni ombrosi e l’illuminazione scarsa, c’è il lavoro pazzesco sul sonoro (qui arricchito dall’esordio di Trent Reznor e Atticus Ross nel mondo delle colonne sonore) e il gusto infallibile per l’inquadratura composta maniacalmente. Come tutti i film di Fincher anche The Social Network è iper-montato, ci sono continui stacchi, che però non infastidiscono perché ogni inquadratura è velluto sugli occhi, morbida e piacevole, sempre precisa e così chiara che non bisogna rimettere a fuoco ogni volta il fulcro dell’azione o anche solo chi stia parlando. Ci saranno un milione di punti di inquadratura diversi per ogni conversazione e spesso anche il campo controcampo cambia lungo l’interazione!
E pensare che un film così difficile doveva in origine essere il film d’esordio alla regia di Sorkin!
Sarebbe stato impossibile. Lo script era di 169 pagine, cioè circa 169 minuti di durata, con così tanti dialoghi che si potevano anche superare le 3 ore. Fincher ne fa invece un film di 120 minuti. E si vede. The Social Network corre tantissimo, complice la musicalità del dialogo di Sorkin, sembra un fiume che non si ferma mai, senza momenti morti. Non se li può permettere.

Fincher aveva registrato Sorkin che leggeva la sua stessa sceneggiatura e l’aveva cronometrato. Aveva capito che solo lui sapeva quale dovesse essere il tempo di quei dialoghi. Fissandosi dei tempi entro cui stare riusciva ad imporre quel ritmo agli attori e a comprimere tutto così tanto da dover in certi casi lavorare al tempo stesso sul primo piano e sullo sfondo per non sforare con il timing che si era dato.
Del resto improvvisazione non poteva essercene, Sorkin come spesso gli capita aveva scritto anche le indecisioni, gli “mmh…”, “a-ahem” e le parole masticate e poi ripetute. Qualsiasi variazione o aggiunta mandava a monte la coreografia tra immagine e parola di questo film.
Ma fin qui arriva la tecnica. La parte sorprendente tuttavia sta nell’approccio. Chiunque altro al posto di Fincher avrebbe fatto di questo film sull’origine del software più noto del momento un film celebrativo oppure una condanna tecnologica, chiunque avrebbe cavalcato la qualità da “tribunale” di uno script eccezionale. Fincher invece con quel cast di ragazzi nuovi e freschi ne fa un film di college che cambia quello che pensiamo del cinema di college. In questo senso è un John Hughes spostato un po’ in avanti nel tempo, quando la scuola è finita. Harvard ha le stesse caratteristiche dei film di college: ci sono gli amori, il desiderio costante di far sesso, le confraternite, gli scherzi come quello della gallina che ha mangiato pollo, c’è il preside arrogante che non capisce i giovani e ci sono i club esclusivi e gli sfigati (e anche i cartelli finali con cosa sia successo ai personaggi come in Animal House), solo che è tutto piegato da una determinazione di ferro.

La qualità incredibilmente contemporanea del film sta proprio in questo cambio: le università non sono più un posto divertente anche se hanno tante feste, perché anche le feste servono a conoscere gente, anche le feste sono competizione, esclusione, frustrazione. Tutto è grigio, tutto è duro, nulla è leggero: “Io non voglio tornare alla festa caraibica” dice ad un certo punto Zuckerberg a Saverin rinfacciandogli un evento da sfigati a cui lo aveva trascinato. Il college qui non è un mondo che prepara allo scontro lavorativo, è il territorio di scontro in cui si decide tutto. In cui si diventa qualcuno oppure dopo sarà tardi.
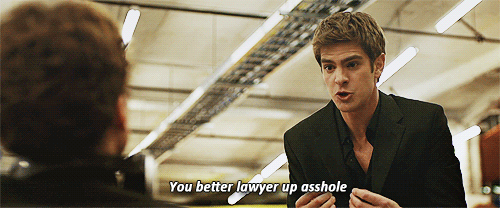
La tensione e soprattutto la pressione per diventare qualcuno, fare soldi, creare, essere i migliori, è giustificata nello script dalla frustrazione di Zuckerberg per non essere stato ammesso nel giro di quelli che contano, ma è nelle immagini e nella recitazione un martello che affligge tutta quella generazione che si sente irrealizzata e lotta per realizzarsi in fretta. Eduardo Saverin terrorizzato da cosa dirà il padre del fallimento, Zuckerberg ossessionato dalle storie di Silicon Valley e l’arrivo come un Dio, come un mito, di Sean Parker, l'unico che Zuckerberg guardi con ammirazione e non tratti male, il suo idolo, l’uomo che distrusse l’industria musicale.

Tangenzialmente poi The Social Network cambiò anche il mondo dei trailer, introducendo e rendendo noto l’espediente ancora copiato (da noi addirittura hanno iniziato a farlo solo ora) delle cover eteree. Il trailer infatti usava Creep dei Radiohead in una versione del coro femminile belga Scala e dei fratelli Kolacny, molto delicata e d’atmosfera a contrasto delle immagini di felici condivisioni.